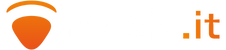“Nella giungla delle città” è un’occasione mancata per tutti. A partire dalla Compagnia Cavalierimascherati, che rivela davvero poco delle sue doti attoriali, castrate da scelte registiche poco lungimiranti. È vero che Bertolt Brecht è una sfida ardua. Il papà del tanto chiacchierato teatro dell’assurdo si presta poco facilmente alla messa in scena. E per di più “Nella giungla delle città” è solo il suo terzo copione. Ciò nonostante vi si trovano i frutti quasi maturi di un teatro critico. La fruibilità di contenuti ostici anche solo alla lettura dipende in toto da un attento lavoro drammaturgico. Servirebbe una formula che non condanni il copione a essere solamente “recitato”.
“Nella giungla delle città” è un’occasione mancata per tutti. A partire dalla Compagnia Cavalierimascherati, che rivela davvero poco delle sue doti attoriali, castrate da scelte registiche poco lungimiranti. È vero che Bertolt Brecht è una sfida ardua. Il papà del tanto chiacchierato teatro dell’assurdo si presta poco facilmente alla messa in scena. E per di più “Nella giungla delle città” è solo il suo terzo copione. Ciò nonostante vi si trovano i frutti quasi maturi di un teatro critico. La fruibilità di contenuti ostici anche solo alla lettura dipende in toto da un attento lavoro drammaturgico. Servirebbe una formula che non condanni il copione a essere solamente “recitato”.
Lo straniamento è la firma di Bertolt Brecht. Lo restituisce anche lo spettacolo curato da Alessandro De Feo, ma in maniera molto diversa. Lo schema rigidamente scolastico in cui ha fatto muovere le maschere ha il magro pregio di non rischiare di far perdere gran parte delle parole. In uno spettacolo in cui ogni singola sillaba è dannatamente fondamentale nella ricostruzione del messaggio brechtiano. Eppure molte si sono perse in pronunce imperdonabili.
“Nella giungla delle città” non mutua lo straniamento da particolari innovazioni drammaturgiche. Persino Bertolt Brecht non ha osato liberarsi della scenografia, che torna sul palco di Teatro Trastevere, essenziale e curata al contempo. Richiede tutta l’abilità di Alessandro De Feo a orchestrare e coordinare tempi e movimenti per i molteplici cambi di ambientazione nell’arco della performance. Non c’è abbattimento della quarta parete, perché non è previsto dal copione. Cosa si fa, allora, veicolo della drammaticità del messaggio brechtiano? Cosa dovrebbe portarci a capirlo se non il corpo e la voce degli attori?
“Nella giungla delle città” è un’occasione mancata per tutti. A partire dalla Compagnia Cavalierimascherati, che rivela davvero poco delle sue doti attoriali.
La drammaticità arriva al pubblico solo per il significato delle parole enunciate. Scavare in sé per trovare una qualche reazione all’esperimento teatrale e sociale de “Nella giungla delle città” di Bertolt Brecht è inutile. Nella società liberal-industriale, chi si propone come demiurgo e homo faber di se stesso è sopraffatto dalla difficoltà di reggere la parte del burattino che si è scelto. Ma il burattino si anima e diventa un bambino vero, e anche maturo per giunta.
Ma Garga non è mai stato un burattino nelle mani di Shlink. E allora la giungla si fa metafora della struttura sociale, della frenesia della vita industriale delle città. Anche se provassimo a considerarla un sistema chiuso, non ci sarebbe comunque una parvenza di ordine a riempire di senso il susseguirsi degli eventi. La giungla potrebbe essere un elegante esercizio di stile, un folle gioco alla decostruzione morale per i potenti della terra. Ma “Nella giungla delle città” non c’è scampo neanche per i predatori.
Non c’è ragione, non c’è un perché dietro la presunta di vittoria di Garga su Shlink. Eppure chiunque avrebbe scommesso sulla vittoria del malese. Tutti pensano che il suo giallo derivi dall’essere cinese, ma Shlink è da quando ha 7 anni che vive a Chicago. Una vita d’inferno la sua, riscattata da quarant’anni di duro lavoro e risultati più che soddisfacenti. Poi arriva il rigurgito romantico, l’ansia del limite, di costruirlo e di superarlo. Aver superato ogni ostacolo senza essere caduto ingenera inquietudine e depressione.
“Nella giungla delle città” nasce dopo che Shlink scambia la sua vita con quella di Garga, in una vera e propria costellazione di crisi e difficoltà.
L’Altro si fa cura dell’individualismo monadico in cui Shlink è rinchiuso, ma in una maniera altrettanto patologica. Non conoscendo relazione, l’unico modo per entrare a contatto con l’Altro è prendere il suo posto. Così nasce “Nella giungla delle città”, dopo che Shlink scambia la sua vita con quella di Garga, in una vera e propria costellazione di crisi e difficoltà. Il bibliotecario fa l’esperienza dell’onnipotenza, mentre il milionario fa esperienza dell’ineluttabilità. Il continuo controcanto tra Garga e Shlink non convince affatto. Si passano la palla in continuazione nel tentativo sincero di rovesciare l’altro, ma in un modo che non è attorialmente genuino.
Stanno solo recitando. A mancare è una lettura, un’interpretazione, una comprensione. Sono molte le scelte del regista Alessandro De Feo a non trovare una spiegazione. Tra cui anche l’incoerenza tra pochi e timidi tentativi di interpretazione più verosimili (Marie e Mrs. Maynes) e caricature grottesche (Jane, Mae, John e i compari di Shlink). Non è mancato qualche refuso di scena, come degli oggetti non pervenuti. Persino il maestro Massimo Ricciardi, che ha eseguito in live la dolceamara e originale colonna sonora composta per l’occasione, è fuori posto. La sua musica sparisce dietro una montagna di buone intenzioni.